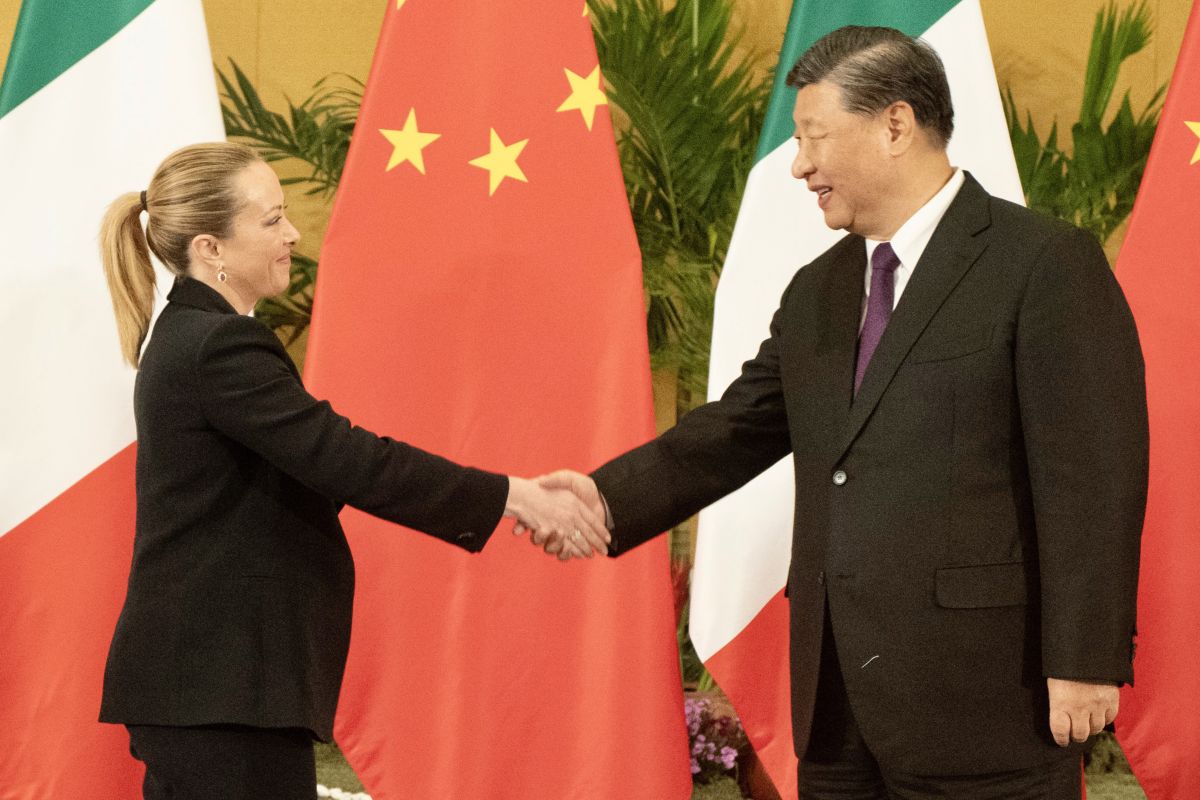Durante il simposio di Jackson-Hole che i è chiuso nel week end, nessuno, tanto meno il “padrone di casa” Jerome Powell ha fatto menzione della crisi cinese. Una crisi che non piove all’improvviso e che ha origini lontane.
Si fa un gran parlare, in queste settimane, della crisi immobiliare (peraltro, quasi a smentire la pesantezza della situazione, oggi riprendono le contrattazioni di Evergrande, una delle maggiori società di sviluppo immobiliare del Paese, sospese dal marzo 22), che ha costretto nuovamente la Bank People of China ad intervenire, seppur in maniera meno incisiva di quanto si pensasse. I “numeri” cinesi confermanouno stato di salute un po’ precario: il rapporto debito/Pil ha ormai raggiunto il 280%, a conferma di un “centralismo” piuttosto invasivo (quello americano, seppur dopo le potenti misure di stimolo che hanno fatto seguito al Covid – e che non si sono ancora fermate – è al 120%), i consumi incidono appena per il 38% del Pil (contro il 70% di quello americano), l’economia fa fatica a mantenere la traiettoria del 5%, “desiderata” del Governo (più probabile che stia tra il 3 e il 3,5%). Ma forse il dato più preoccupante ed eloquente è quello relativo alla disoccupazione giovanile, vicino al 21%, che significa, vista la popolazione di oltre 1,4ML di abitanti, milioni di giovani senza lavoro.
Il fatto che dalle parti del Wyoming (che in realtà, in quella circostanza, aveva una valenza ben più ampia, raggruppando, di fatto, tutte le economie sviluppate, mentre quello in “via di sviluppo”, negli stessi giorni, erano in assise a Johannesburg), non si sia fatto il minimo cenno alle vicende cinesi, oltre ad assumere un contenuto politico (ogni cosa ha sempre un contenuto politico), probabilmente sta a significare che i Paesi occidentali (e quindi le economie più forti) non temono la crisi cinese e ritengono che la stessa non avrà alcun impatto a livello globale. Il timore, neanche troppo velato, di molti era che il mondo si trovasse nuovamente di fronte ad una nuova “Lehman Brothers made in China”.
Molte sono le differenze tra la crisi che sconvolse e ha cambiato il mondo nel 2008 e quanto sta avvenendo in queste settimane a Pechino.
Partiamo con il dire che, seppur il debito cinese, come detto più sopra, abbia raggiunto livelli record, è un debito soprattutto “domestico”: non è cioè detenuto da creditori esteri, che da un momento all’altro possono “richiedere indietro “ il loro denaro (o chiudere le linee di credito).
In secondo luogo, gli investimenti stranieri in quel Paese, per quanto siano cresciuti, sono tutt’ora relativamente modesti.
Gli Stati Uniti, per esempio, tra Cina e Hong Kong, hanno investimenti diretti (quelli che comportano un controllo) che non superano i $ 215 MD. Se comprendiamo gli investimenti in portafogli mobiliari (azioni ed obbligazioni) dobbiamo aggiungere $ 300 MD circa. Si arriva, quindi, a $ 515 MD: cifra non piccola, ma, viste le dimensioni della ricchezza globale, quasi irrisori (il valore degli edifici adibiti ad uffici, solo per rimanere negli Stati Uniti, oggi è stimato in circa $ 2,6 trilioni).
Se poi si analizza quanto vale la Cina per l’economia statunitense, il quadro risulta ancora più chiaro.
Il PIL Usa vale approssimativamente tra i $ 18.000 MD e i $ 20.000 MD: la Cina acquista prodotti americani per un valore che non superano i $ 150 MD. Meno, quindi, dell’1% (valori 2022). Ne consegue che una eventuale recessione cinese, per quanto non possa certo essere una buona notizia per l’economia globale, non influenzerebbe più di tanto l’economia “stelle e strisce”, mentre avrebbe un impatto senz’altro peggiore per quei Paesi (come la Germania o il Giappone) che intrattengono più stretti rapporti commerciali.
Ciò detto, meglio sarebbe, a livello globale, che quel Paese fosse “in salute”: magari “non troppa” (tassi di crescita come quelli visti in un passato non troppo lontano, con livelli che superavano il 10% annuo, porterebbe a problematiche forse ancora maggiori, soprattutto a livello geo-politico), ma comunque in grado di assicurare uno sviluppo generalizzato ed evitare tensioni sociali che potrebbero avere ripercussioni non lievi in un Paese “dirigista” come è Pechino.
la settimana si apre con tutti gli indici asiatici in sostenuto aumento, favoriti, soprattutto quelli cinesi, dalle iniziative delle autorità monetarie di Pechino, che hanno deciso di dimezzare le imposte sulle transazioni azionarie, oltre che rallentare il numero delle operazioni di offerte pubbliche iniziali, stupendo positivamente chi si aspettava misure più limitate. A Tokyo il Nikkei sale dell’1,73%, mentre Shanghai e Hong Kong sono poco sopra l’1% (rispettivamente 1,09 e 1,22%). Bene anche le altre piazze del Pacifico, da Taiwan a Seul.
In buona salute i futures europei e americani, con rialzi tra lo 0,20 e lo 0,40%.
Riguadagna terreno il petrolio, con il WTI che torna sopra i $ 80 (80,10, + 0,23%).
Strappo del gas naturale Usa, a $ 2,729 (+2,56%).
Oro a $ 1.927 (+ 0,21%).
Spread che non si schioda dall’area 160-170 bp: questa mattina lo troviamo a 165 bp.
Rendimento dei BTP a 4,23%, livello assolutamente identico al Treasury Usa.
Bund tedesco a 2,55%.
€/$ poco mosso, a 1,082.
Sempre debole il bitcoin, che stenta a risalire oltre i $ 26.000 (25.932, – 0,61%).
Ps: e dunque oggi ci sarà l’ufficializzazione di Roberto Mancini come nuovo Commissario Tecnico dell’Arabia Saudita. Ovviamente non ci sono precisazioni sull’ingaggio, ma si parla di una cifra che varia tra i $ 18ML e i $ 25ML annui. Il “mal di pancia” del “Mancio” ha dunque, come si supponeva, delle spiegazioni molto poco “filosofiche” e più “terrene”. Anzi, molto terrene. Difficile resistere al richiamo di così tanto “denaro sonante”: magari, però, da chi sa vestire con tanta eleganza, ci si poteva attendere un comportamento altrettanto elegante. Bastava dire: mi offrono una marea di soldi, come faccio a resistere, tengo famiglia anch’io…..(anzi, 2).